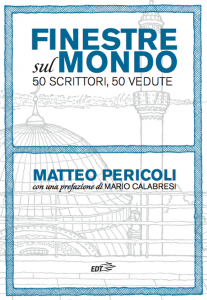Il Tai chi chuan a Torino: un esempio di mediazione culturale
Il Tai chi chuan a Torino: un esempio di mediazione culturale.
Corsi e ricorsi della storia e della memoria.
12 marzo 1996.
La mia Tesi di Laurea sul Tai chi chuan
La prima Tesi di ricerca accademica sulla pratica del Tai chi chuan in Italia.
Dalle pagine preparate allora per un Concorso, poi vinto, un breve estratto:
Possa tu vivere in tempi interessanti
antico motto cinese
La società che abitiamo e che viviamo presenta, sul finire di questo secolo, elementi di grande interesse e curiosità per tutti coloro, e non solo, che si interessano all’uomo e al suo rapporto con il “mondo” e nel “mondo”. I processi di diversificazione, moltiplicazione, diffusione dei fenomeni e delle “culture” rendono più facilmente manifestabili, raccoglibili, studiabili i nuovi “percorsi” che coinvolgono il soggetto nei suoi processi di socializzazione primaria e secondaria, di identificazione e di individuazione, di costruzione e strutturazione permanente della propria identità.
Il tentativo di porre attenzione alle nuove dinamiche culturali, frutto di un multiculturalismo sempre più variegato e multiforme, unito ad un affetto profondo per la Cina e il suo universo culturale, mi ha portato a rivolgere la mia ricerca al Tai chi chuan.
Il Tai chi chuan è una disciplina di origine cinese che abbina in sè movimenti lenti ed armoniosi tramandatisi nel tempo dall’antichità ad alcuni principi della filosofia taoista e della medicina cinese. Alcuni lo considerano di meditazione in movimento che collega il microcosmo individuale al macrocosmo universale attraverso l’esecuzione di movimenti morbidi di straordinaria bellezza formale. C’è qualcosa di indefinibile nella pratica di questa disciplina che sfugge a qualsiasi tentativo di descrizione.
La mediazione culturale, secondo questa ricerca, è un processo intrasoggettivo che si attiva quando l’attore sociale entra in contatto con un universo simbolico e culturale diverso dal proprio. La mediazione diventa espressione della permeabilità delle nostre società ed indica, se affrontata con modestia culturale, la interpenetrazione possibile dei differenti universi culturali dell’uomo a fronte di una cultura universale dell’uomo.
La specificità della ricerca ha reso necessario l’utilizzo di strumenti di indagine complessi (questionari, interviste semi-strutturate, schede di rilevazione dati) idonei alla raccolta dei dati necessari alla costituzione di una prima banca dati inedita sul Tai chi chuan.
Dai risultati della ricerca risulta piuttosto chiaramente che il processo di mediazione culturale in atto non riguarda solamente ed esclusivamente la cultura cinese e la cultura autoctona, di matrice occidentale. Sembra emergere la presenza di un terzo polo culturale che assume sempre più valore ed importanza. Un universo culturale che trascende le culture particolari e che si colloca in una dimensione “altra”.
Riemerge forte la centralità dell’uomo e della sua ricchezza particolare, singolare, unica. Rinasce un nuovo umanesimo. L’Umanesimo di fine millennio.